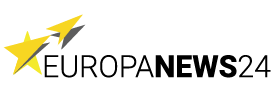All’inizio del libro di Samuele è scritto: “poi un uomo della stirpe di Beniamino corse nello stesso giorno dalla linea di battaglia e giunse a Shiloh con i vestiti strappati”.
Sento il sudore scivolare lungo le guance. Tengo a freno la mano, il polso, che vorrebbe allungarsi ad asciugare quel rigagnolo che ha scavato un piccolo solco. Guardo il cartello che lentamente scorre alla mia destra. C’è un numero, il 36. Ne mancano ancora sei all’arrivo. Questo è il momento di ragionare, di controllare ogni gesto. E’ il tempo del risparmio energetico. Quando corri una maratona lo devi fare con tutti i sensi che la fatica inevitabilmente tende ad affievolire con il passare dei metri, dei minuti, delle ore.
Certo, c’è la testa a governare tutto. Ma non è lei il fattore determinante, quella che fa la differenza. Perché c’è un momento in cui lo scorrere del tempo allunga i tempi di reazione. La vista non è più pronta, rischi di perdere quei cartelli disegnati di rosso che uno dopo l’altro ti allontanano dalla partenza per avvicinarti all’arrivo. Il gusto ha imparato da parecchi chilometri a riconoscere il salato del sudore. Anche gli incitamenti arrivano più dolci, così come gli sguardi dei soldati che sono lì, piazzati come angeli protettori a darti serenità. Sono giovani, loro, sono terribilmente giovani, loro, e vergognosamente riposati. Le gambe diventano sempre più pesanti. Mi chiedo perché, perché un individuo all’apparenza normale debba decidere di affrontare una follìa qual è una maratona. E poi sono vecchio, troppo vecchio. Continuo a ripetermelo, non so darmi una risposta. Cerco scuse. Vedo il paesaggio e mi convinco. Ma quando mai avrei potuto correre in Israele, a contatto con queste montagne dove altri uomini, altre donne, hanno scritto la storia dell’umanità.
Ho 65 anni, i tempi in cui correvo dietro a un pallone sono lontani.
Ero un’ala, anche veloce. Era difficile prendermi. Non avrei immaginato di finire così, affrontando maratone, ultramaratone, traversate a nuoto macinando chilometri, per passare dalla Sicilia alla Calabria. La mente scorre a quell’ultima bracciata che mi fa toccare Cannitello. Sono trascorsi quattro anni dalla conquista dello Stretto di Messina, il ricordo serve a rinfrescarmi, a farmi dimenticare quel rigagnolo di sudore che complice i 30 gradi di Shiloh diventa sempre più impetuoso, sempre più dispettoso.

Quando affronti una maratona devi crearti punti di riferimento. L’esperienza conta parecchio. Bisogna occupare la mente quel tanto per liberarti dal peso della fatica, da quell’ossessione che ti porta a guardare di continuo l’orologio, a controllare il tempo, verificando i passaggi dopo dieci, venti, trenta chilometri. Sono questi gli immaginari cancelli, i muri da abbattere. L’esperienza accumulata in dodici anni di maratone mi hanno insegnato che è sempre una nuova avventura, non c’è gara uguale all’altra. Troppo diverse le condizioni ambientali, lo stato di forma, l’età che scorre, per immaginare che New York sia uguale a Londra, Roma, Parigi, Berlino, Venezia, Boston, Stoccolma…

Qui è tutto diverso. Non solo per il paesaggio.
Correre la maratona della Bibbia significa vivere il passato, il presente, il futuro.
La storia vuole che questo stesso percorso sia stato fatto di corsa da un uomo della stirpe di Beniamino che macinò 42 chilometri, dal campo di battaglia di Ebena Ezer, la moderna Rosh Ha’ayin, fino alle rovine di Shiloh per raccontare la fine della guerra tra ebrei e filistei. A differenza di Fidippide, ambasciatore di vittoria nella guerra tra Atene e i persiani, il nostro uomo di Beniamino informò Eli, sacerdote di Israele, della morte dei suoi figli, della perdita dell’arca dell’Alleanza e della sconfitta nella battaglia. Molti secoli dopo, dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967 tra israeliani ed egiziani, Yosef Yekutieli, ideatore delle Maccabiadi, ha misurato il percorso da Rosh Ha’ayin a Shiloh, scoprendo che la distanza era la stessa della moderna maratona: 42 chilometri. Da qui la nascita della maratona della Bibbia sullo stesso storico percorso. Questo è un posto magico. Shiloh è nell’anima degli ebrei. Nonostante non ci siano grandi palazzi o possenti mura, è uno dei luoghi più affascinanti di Israele. Qui, nel territorio della tribù di Ephaim i bambini hanno portato il Tabernacolo, rendendo Shiloh centro religioso anche prima di Gerusalemme, altra città dove anche chi non crede sente la presenza di Dio.

Penso, tengo occupata la mente. Il cartello numero 37 è appena superato. La strada s’impenna. La maratona della Bibbia è forse la più dura della mia carriera. Si comincia a salire subito. All’inizio il pendio è dolce, poi man mano la gobba si allunga. E’ così per i primi dieci, venti chilometri. A guardare quella strada che seppure lentamente, ma inesorabilmente, continua per i primi ventisei chilometri continuo a chiedermi, “Ma prima o poi dovremo tornare a scendere, no?”. Deve succedere e succede. Ne mancano sedici, di chilometri all’arrivo e finalmente vedo la terra promessa, fatta come un monte Bianco visto al contrario. Per un attimo dimentico la fatica, il sudore. Stavolta il braccio si alza, asciuga la fronte, posso dedicare anche qualche ulteriore sforzo a quel rigagnolo che ormai ha scavato la mia guancia facendolo sembrare un torrente. Mi butto a capofitto. Sogno un arrivo in volata. Sedici chilometri tutti di un fiato grazie alla discesa che dovrebbe regalarmi tempi da favola. L’illusione dura una manciata di chilometri, appena quattro, quattro e mezzo, forse cinque.

Poi si torna a salire. Mi sento affranto, deluso, amareggiato, improvvisamente svuotato di forze. Sento forte il bisogno di piangere, di lasciarmi andare. Mi chiedo: “ma come posso affrontare in queste condizioni, altri dieci chilometri”. E le gambe di colpo diventano tronchi, anche l’anca destra comincia a farmi male. La massaggio senza smettere di correre. C’è una tecnica al proposito. Devi massaggiare sfruttando il ritmo del movimento. Funziona, o meglio, mi impongo che possa funzionare. Mi impongo anche di non guardare più, almeno per un po’, i cartelli che indicano i chilometri percorsi. Pure questo è un trucco che a volte funziona. Ma è un’arma che ti si può ritorcere contro. Quando torni a vederli potresti scoprire di essere più indietro di quanto sperato. Se resti deluso è una mazzata, se sei piacevolmente sorpreso è come se qualcuno improvvisamente cominciasse a spingerti. Ho voglia di arrivare e la faccenda funziona. Ma l’arrivo è ancora lontano. Trentasette, trentotto chilometri. Ne mancano appena quattro, sono i più duri, ma che importa è quasi fatta, anche camminando potrei arrivare. No, camminare proprio mai, non è dignitoso. Per un attimo resto sorpreso, un gruppo di sei maratoneti mi sorpassa di buon passo. Non comprendo, ma vado così piano? Poi capisco. Il percorso della mezza maratona si è intrecciato con quella della maratona. Loro sono ancora freschi. Non mi va di fare la figura di quello distrutto. Per qualche centinaia di metri riesco a stargli dietro. Dura poco, il loro ritmo è troppo più alto del mio, ma lo sforzo più che stroncarmi, mi rinfranca, mi aiuta ad avvicinarmi a quel traguardo che ormai sento vicino. Sono come un cane che bracca la preda. E la preda è il cartello dei 42. Non manca molto, ma gli ultimi due chilometri sono davvero i più duri, e non tanto per la fatica. Lascio la strada principale, morbidamente asfaltata, per infilarmi in un sentiero pieno di sassi.
 Il percorso mi porta verso la cime della collina che regala una magnifica vista sulla valle dove ha avuto luogo una delle storie più affascinanti raccontate nella Bibbia, la festa per la raccolta dell’uva quando le figlie di Shiloh arrivarono danzano e gli uomini di Beniamino cercarono le mogli tra di loro. La mia mente distoglie il corpo solo per qualche istante. Le mie caviglie urlano, i muscoli urlano, solo la testa è felice. 41, 42, ecco mancano appena 195 metri. E’ fatta. Sento Beniamino vicino. Lui, l’eroe vero, io il vecchio che non ne vuole sapere di morire vecchio. E taglio quell’immaginario filo che segna l’impresa personale. Telecamere, abbracci, la medaglia da infilare al collo. Ho ancora voglia di baciare la miss. Cosa mai potrei volere di più?
Il percorso mi porta verso la cime della collina che regala una magnifica vista sulla valle dove ha avuto luogo una delle storie più affascinanti raccontate nella Bibbia, la festa per la raccolta dell’uva quando le figlie di Shiloh arrivarono danzano e gli uomini di Beniamino cercarono le mogli tra di loro. La mia mente distoglie il corpo solo per qualche istante. Le mie caviglie urlano, i muscoli urlano, solo la testa è felice. 41, 42, ecco mancano appena 195 metri. E’ fatta. Sento Beniamino vicino. Lui, l’eroe vero, io il vecchio che non ne vuole sapere di morire vecchio. E taglio quell’immaginario filo che segna l’impresa personale. Telecamere, abbracci, la medaglia da infilare al collo. Ho ancora voglia di baciare la miss. Cosa mai potrei volere di più?